Un piatto che ha fatto tremare i conquistatori | La verità finalmente svelata dietro la lotta tra Arancina e Arancino
Scopri la battaglia secolare tra arancina e arancino: sapori, storia e orgoglio dei palermitani in un duello culinario che vive ancora!

Le origini arabe che hanno ispirato Palermo
Le radici dell’arancina/arancino affondano nel periodo della dominazione araba tra IX e XI secolo, quando i Saraceni introdussero nella cucina siciliana il riso con zafferano, aromi e carni, impastato a mano per creare palline da viaggio. Queste prime “polpette dorate” avevano lo scopo di resistere al trasporto, durare a lungo e alimentare soldati e viaggiatori—qualcosa che i conquistatori trovarono sorprendentemente efficace, tanto da prenderne ispirazione e riproporle nei loro forzieri gastronomici. Nella tavola palermitana, già allora, si iniziava a delineare il destino “da snack da strada” che questo piatto avrebbe avuto nei secoli successivi.
Arancina o Arancino? Il campanilismo che scuote Palermo
Nel cuore di Palermo, la guerra tra arancina (forma tonda, femminile) e arancino (forma a punta, maschile) è una battaglia che divide famiglie, chef e interi quartieri . I palermitani adottano con orgoglio la forma “arancina”, rotonda, simbolo ideologico della Sicilia Occidentale, mentre la Sicilia Orientale preferisce la versione “arancino” triangolare, richiamo all’Etna. L’Accademia della Crusca ha riconosciuto la validità di entrambe, ma a Palermo il dibattito è un fatto di tifoseria locale con passioni da stadio e storie da bar che partono all’alba nel mercato del Capo e si consumano fino a notte inoltrata sotto i lampioni della Vucciria.
L’evoluzione tra dolce, salato e… strategia di guerra
Nel Dizionario siciliano-italiano di Giuseppe Biundi (1857) l’arancino era “una vivanda dolce di riso fatta alla forma della melarancia”. Poi nel 1868 Antonino Traina inserì la versione salata, con ragu, formaggio e piselli: la trasformazione glaciale da dolce festivo a esplosione gastronomica street. La panatura, legata alla corte di Federico II, ottimizzava la conservabilità in battute di caccia o nelle campagne—una scelta strategica da “assalto gastronomico” che i conquistatori avrebbero invidiato.
Il Piatto Patrimonio dei Palermitani e Orgoglio Globale
Oggi, l’arancina è il simbolo dello street food palermitano, riconosciuto come Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT) del Ministero. All’interno, un cuore morbido di ragu, piselli e caciocavallo, racchiuso in riso allo zafferano e avvolto in pangrattato croccante. Ne esistono versioni con burro, mozzarella, spinaci, tonno e persino varianti dolci. Inoltre, il suo arrivo nei banchetti palermitani ha aggiunto un pizzico di orgoglio locale, trasformando un’eredità araba in bandiera cittadina. Non un semplice snack, ma una croccante identità.
Curiosità
La vera potenza dell’arancina risiede nella sua capacità di nascondersi sotto un aspetto innocente: crosta dorata, dimensioni da boccone, ma al suo interno un’esplosione di sapori – una strategia ingannevole simile alle tattiche militari con cui i conquistatori venivano battuti a tavola. Quando gli Spagnoli e i Borboni arrivarono nell’isola, furono persuasi da questo fingere semplicità: sembrava un modesto cibo da strada, ma nascondeva ingredienti nobili come zafferano, carne di agnello e formaggio. In un’epoca in cui il controllo del territorio andava di pari passo con la capacità di sostenere le truppe, l’arancina – portatile e nutriente – divenne un complemento perfetto.
Pare che durante la dominazione spagnola, il boccone veniva utilizzato per “valutare” le capacità di integrazione e gestione locale: chi non apprezzava l’arancina non era “degno” di governare Palermo nelle festività, dato il valore simbolico legato alla resistenza civile. Inoltre, trova origine nel fatto che l’arancina permetteva ai contadini palermitani di continuare il lavoro nei campi senza dover tornare in paese per mangiare, rivoluzionando l’organizzazione del lavoro. Questo li rese più efficienti e… insostituibili, tanto che gli amministratori del viceré dovettero concedere loro piccole autonomie tipiche che hanno anticipato le attuali forme di autonomia agricola e sindacale. Un vero colpo di stato… gastronomico!
Questo duello tra arancina e arancino portò anche a differenze religiose: durante la festa di Santa Lucia, il 13 dicembre, a Palermo si consumano solo arancine e cuccìa – un'usanza che ricorda come i palermitani abbiano adattato il piatto alle tradizioni locali, trasformando un cibo “da mercato” in un rito collettivo. La concomitanza con i festeggiamenti crea una sorta di rituale urbano, una gara tra quartieri per la miglior variante, recentemente documentato in reportage TV e social locali.
Molti palermitani raccontano che un morso d’arancina dà la sensazione di mordere la storia stessa di Palermo, perché contiene tutti i suoi dominatori, i suoi tonfi epici, e l’irresistibile voglia di ribellione. Non è un’esagerazione: i conquistatori impararono presto che sotto una croccante scorza potevano nascondersi guerrieri: arancine pronte a conquistare gli stomaci e i cuori. Ancora oggi, ogni pasticceria palermitana difende la propria ricetta come fosse un forte, e le discussioni sul genere (“-ina o -ino?”) diventano scontri con lo stesso ardore dei duelli storici nella Conca d’Oro.
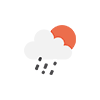 10.6°
10.6°


